|
L’altipiano del
Renon è un’amena zona di media
montagna posta a circa 15 km dal
centro del capoluogo Bolzano. Essa
offre tante opportunità di svago che
vanno dal semplice soggiorno
all’esercizio di sport invernali
potendo offrire una gamma di
altitudini dai 500 ai 2200 metri
s.l.m. Per molti secoli, la località
è rimasta non dico isolata, ma di
certo con molte difficoltà di
accesso consentito solo attraverso
tratturi e con l’ausilio di bestie
da soma. Ciò tuttavia offriva ai
villeggianti il vantaggio di
sentirsi in una zona tranquilla ed
esclusiva, lontana dall’invasione
del turismo di massa.
Quindi qualunque mezzo di trasporto
moderno ed innovativo, che si
ventilava sul finire dell’800 per
porre fine al secolare isolamento
della zona, veniva visto dai
privilegiati villeggianti con
ostilità. Ma
purtroppo (o fortunatamente) il
progresso cammina.
L’enorme
disponibilità di energia elettrica
proveniente da nuove centrali
idroelettriche indusse un comitato
promotore, costituitosi ad hoc,
a sollecitare la redazione di un
progetto che, avvalendosi della
economica elettricità, potesse
realizzare finalmente un comodo
accesso ferroviario all’altipiano
del Renon.
Fra i promotori
di quest’azione c’era l’ingegnere
Josef Riehl, egli stesso azionista
della neo costituita Società ed
esperto progettista di ferrovie. Una
volta tanto, tra il dire ed il fare,
il passo fu breve. Una volta
approvato il progetto, in meno di un
anno, esso fu realizzato. La
costruzione della nuova ferrovia ad
aderenza mista, fu terminata il 22
Aprile 1907 ed inaugurata il
giorno 13 del successivo mese di Agosto.
Pur avendo caratteristiche
tranviarie, la Tranvia del Renon
viene talvolta indicata anche come
Ferrovia del Renon.

Il tracciato
della Tranvia del Renon:
il tratto in blu indica l'andamento
lungo la sede stradale; quello in
rosso la tratta a cremagliera ed
infine quello in verde la
tratta ad aderenza naturale
(elaborazione A. Gamboni). Il tracciato, di
lunghezza pari a 12 chilometri,
superava un dislivello totale di
985 m. Consisteva in un tratto
tranviario di quasi 1 km che
congiungeva piazza Walther, la
piazza principale al “centro” di
Bolzano, con la stazione a valle del
tratto a cremagliera “Bolzano -
Ferrovia del Renon”, allora facente
parte del limitrofo Comune di
Dodiciville.

Una biassi in una rara immagine
a colori degli anni ’50, si appresta
a partire per l’altopiano
da Piazza Walther in Bolzano
(Coll. G. Fiorentino).
Di qui, dietro ogni convoglio diretto
sull’altipiano, si poneva la motrice
di spinta, dotata di ruota dentata
che spingeva il treno sulla ripida
salita alla velocità massima di 7
chilometri orari.
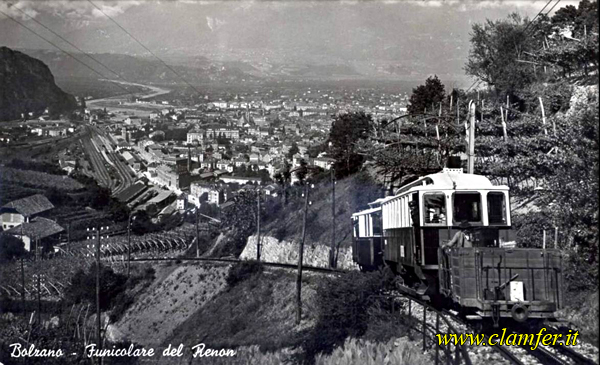
Ancora una biassi in ripida
salita verso l’Assunta con un carro
di servizio
e lo spingitore sul tratto a
cremagliera (Coll. G.
Fiorentino).
Superato il dislivello di 910 metri
che separa Rencio da Maria Assunta,
la cremagliera terminava e lo
“spintore” si allontanava pronto a
porsi davanti ad un convoglio
discendente con la funzione di
freno. Il treno proseguiva sino a Collalbo alla velocità di 25
chilometri l’ora.
La parte a cremagliera era
attrezzata con il sistema “Strub”
al centro del binario di scartamento
1000 mm. ed alimentazione a 800 V.
Due gravi incidenti funestarono
l’esercizio della linea: il 17
maggio 1917 e il 3 dicembre 1964.
Entrambi accaddero sulle rampe sopra
Santa Maddalena con dinamica simile.
La perdita del controllo sulla
frenatura in discesa provocò il
deragliamento della locomotiva e il
rovesciamento della vettura
retrostante. Nel primo perse la vita
il solo macchinista della locomotiva
e furono feriti più o meno
gravemente alcuni impiegati della
ferrovia e vari viaggiatori. Il
bilancio del secondo fu ben più
pesante: oltre alla morte del
macchinista si registrarono altri
tre decessi e numerosi feriti fra i
quasi cento passeggeri.
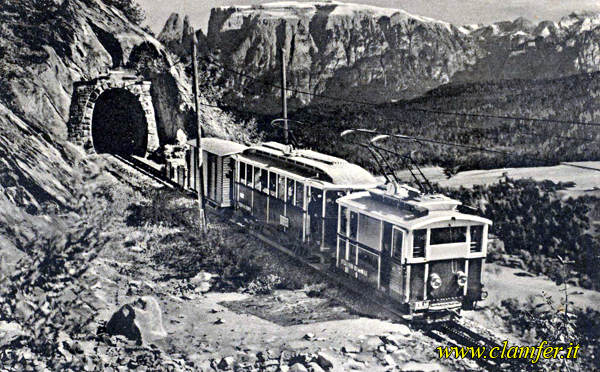
Lo spingitore in discesa con
funzioni di freno è appena uscito
dall'unica galleria (Coll. G.
Fiorentino).
Un luogo comune attribuirebbe a
questo secondo incidente la
decisione della chiusura del primo
tratto della ferrovia e la
conseguente costruzione della
funivia. Ciò non è esatto in quanto
a tale epoca, la teleferica era già
decisa ed in costruzione. Anzi pare
che proprio alcuni carri di servizio
inseriti in un convoglio extra e
destinati a tale cantiere, abbiano
provocato lo svio in seguito ad una
caduta di tensione ed allentamento
dei freni. In ogni caso la tratta a
cremagliera cessò la sua attività il
15 Luglio 1966. Il giorno dopo
l’impianto a fune iniziò il servizio
regolare. Incominciò dunque per il
trenino del Renon un nuovo capitolo
della sua centenaria storia.
L’itinerario si era ridotto ormai a
6,8 km con partenza dall’Assunta e
prima fermata a Soprabolzano in
adiacenza con la stazione superiore
della teleferica. Erano gli anni nei
quali non c’era molto spazio per le
piccole ferrovie e tutti erano
convinti che con l’auto si potesse
andare ovunque. Sembrava che il
nostro tramvetto avesse i giorni
contati. Per fortuna con
l’ostinazione dei cittadini e delle
autorità municipali, si condusse una
strenua battaglia che salvò
l’impianto. La nuova gestione a cura
della compagnia regionale SAD,
produsse ottimi risultati.
In giro per l’Europa, si riuscì a
trovare anche qualche veicolo
dismesso ed adattabile allo
scartamento (tramvia di Eslingen).
Furono sostituiti i binari del
tracciato e la linea aerea
(conservando gl’inconfondibili pali
di legno). Oggi solo alcune corse
arrivano all’Assunta. Perlopiù le
partenze si effettuano da
Soprabolzano fino al capolinea di
Collalbo (Klobenstein) attraverso
varie fermate rurali ed alcune
stazioncine. Nel
2007 ci sono stati grandi
festeggiamenti per il centenario
della storica linea. Nel 2008 invece
sono iniziati i lavori per la
completa ricostruzione della
teleferica. L’impresa è stata
affidata alla blasonata azienda
Leitner di Vipiteno che in men che
non si dica, ha provveduto
a realizzare un impianto moderno e
sicuro, con ampie cabine e nuovi
motori che hanno abbassato i tempi
di percorrenza (già ridotti) a
minuti 12, con una capacità di 550
passeggeri l’ora. Per quanto
riguarda il vecchio tracciato della
cremagliera, esso fu restituito ad
un utilizzo pubblico per un’ascesa
in mountain bike oppure con
attrezzature da trekking.
Per quanto riguarda il materiale
rotabile, esso appare eterogeneo e
di notevole interesse. Va subito
detto che per l’inaugurazione del 1907
furono necessariamente inseriti nel
parco dei rotabili quattro
locomotori a cremagliera Strub
immatricolati dal numero L1 al
numero L4.
Malgrado lo scorrere del tempo, ne
sopravvivono due in quanto L1 rimase
coinvolto nell’incidente del 1964 e
rottamato; l’altro L3 fu altresì
rottamato per cause per così dire
naturali. L2 sopravvive invece,
opportunamente restaurato, nel
deposito sociale; mentre L4
restaurato, fa bella mostra nel
Museo dei tram di Innsbruck.

Spingitore L4 ripreso
dall’autore presso il Museo del Tram
di Innsbruck (Foto di G. Fiorentino).
La motrice Alioth
è appartenuta alla dismessa tramvia
interurbana Dermulo-Mendola, cessata
nel 1934. Pertanto è da ritenersi
che anch’essa abbia requisiti di
storicità risalendo al 1910.

Motrice Alioth in corsa verso
Collalbo (Da sito istituzionale).

Altra immagine con l’Alioth (ex
Ferrovia Dermulo-Mendola) (Coll. G.
Fiorentino).
Delle vetture a due assi della prima
fornitura del 1907, ne sopravvivono
due in perfette condizioni di
esercizio la 11 e la 12. La
dotazione è completata da alcuni
carri merce, da uno spazzaneve,
nonché da una piattaforma per
verifica rete aerea proveniente
dalla dismessa tramvia Bolzano Gries.
In epoca recente, incoraggiati
dall’apertura della nuova teleferica
con prevedibile aumento del
traffico, sono stati acquistati
alcuni veicoli tramviari della
Trogerbahn dotati altresì di
rimorchio. |